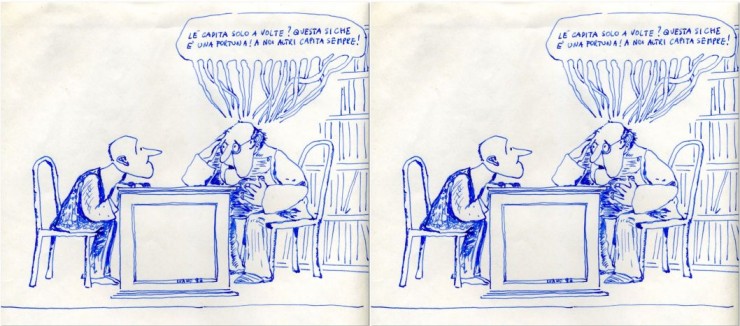|
Cosa vuol dire essere psicoanalisti, oggi? Quale rapporto intrattenere con in lascito freudiano, dopo Freud? Esiste uno specifico irrinunciabile del punto vista psicoanalitico? E se sì, dove si situa nel contesto dei differenti modelli di psicoanalisi operanti? E, di più, nello spazio sempre più vasto e contraddittorio dei diversi modelli di mente operanti nella psicologia contemporanea? Pensiamo siano questi quesiti essenziali per chi, come l'Autore del sito, ritiene ancora, cocciutamente? insuperata la lezione metodologica e il senso interrogativo e critico della psicoanalisi come atteggiamento comunicativo-relazionale e, più ancora, umano-esistenziale di fronte all'enigma della sofferenza umana che si declina anche drammaticamente nel dolore mentale, nella paralisi emotiva, nello smarrimento esistenziale, nell'agito delle perversione e nello splitting psicotico.
|
CONSIDERAZIONI CRITICHE SULL'INTERPRETAZIONE FREUDIANA
DELL'AGGRESSIVITA'
di
IVANO LANZINI e AGOSTINO MASSONE
È, quello che segue, un saggio critico sulle risposte date da ARoN e da MUSATTI agli interrogativi sulle origini dell' aggressività umana riproposti recentemente sulla stampa nel periodo del Convegno Internazionale di St. Vincent sul tema " Psicologia dell'aggressività e della violenza " ( 14-15 ottobre 1980).
Sono così messi in rilievo valore e limiti dell'interpretazione rigidamente freudiana dell'aggressività nell'uomo, anzitutto la tesi della naturale ( strutturale, e quindi innata) aggressività umana, per proporre l'ipotesi che la violenza e la sua versione in " terrorismo " non sia un fenomeno da spiegarsi in un'ottica soltanto psicologica. Si tratta di un fenomeno "sociale" che richiede, in quanto tratto comportamentale ed emotivo-affettivo in stretta relazione, reattiva o di adeguamento, ad una' realtà o sistema sociale in tutti i suoi livelli, una profonda trasformazione culturale, sociale, etico-religiosa della società ed un conseguente impegno civile e politico,
1.
Agli inizi degli anni Trenta, le nazioni rette da governi democratici erano di nuovo con il fiato sospeso per l'avvento di regimi dittatoriali inneggianti ad ideali di supremazia di razza. Le ideologie fasciste in Italia e in Germania rendevano sempre più precaria la pacifica convivenza tra i popoli e la minaccia di una nuova, catastrofica guerra, si profilava all'orizzonte.
La gente comune e gli uomini di cultura si chiesero, con maggior insistenza del solito, perché il mondo "civile" dovesse ricorrere, con periodica ineluttabilità, alla guerra. La Società delle Nazioni si fece interprete di questi sentimenti e di questi interrogativi e sollecitò una risposta ai più prestigiosi esponenti della cultura di quell'epoca. I primi uomini di scienza ad essere interpellati furono Einstein e Freud. Tra questi due insigni studiosi intercorse, così, uno scambio epistolare che fu in seguito pubblicato nel volume " Perche la guerra? ". La situazione internazionale agli inizi degli anni ottanta, non è certo più distesa di quella esistente 50 anni fa, in particolare l'aggressività e la violenza non mostrano segni di assopimento o di diminuzione. Per contro esse si manifestano in termini diversi ma non meno crudi di allora. Le domande sul significato della guerra e quindi sulle cause della violenza, poste 50 anni fa ai due illustri scienziati, sono ancora attuali e il nostro più diffuso quotidiano, " Il Corriere della Sera ", ha ritenuto opportuno riproporre gli stessi interrogativi sull'origine dell'aggressività umana, che si esprime attualmente anche nel terrorismo, a un politologo famoso, il francese Aron, e a un discepolo di Freud non meno famoso, l'italiano Musatti. Le loro risposte comparvero sul " Corriere " del 16-10-1980. Tali risposte, ed in particolare quella di Musatti, furono oggetto q i discussione nel meeting settimanale che tengo con i miei .Allievi in analisi didattica. Ne emersero considerazioni interessanti sui valori e sui limiti dell'interpretazione rigidamente freudiana dell'aggressività umana, considerazioni che sono state in parte espresse da uno dei compartecipanti. Oltre all'autore, Ivano Lanzini. del saggio critico che presento, i partècipanti al Gruppo erano le Dott.sse Dal Magro F" Muscarà E, e Sanesi P.; i Dott.ri Buzzi E. e Invernizzi E. e la Sig.na Vismara p ., laureanda in Medicina.Poichè " Anime e Corpi " ha già trattato il tema della violenza, ritengo che la conoscenza di quanto scritto dal Dott. Lanzini sia utile ai lettori, anche come complemento al mio articolo sull'aggressività, comparso sul n. 75, del gennaio-febbraio 1978, della Rivista,
2.
L'analisi di C. Musatti sulla violenza e il terrorismo è così chiara e lineare da apparire veritiera. In realtà non mi pare che sia tale; che sia, cioè, una analisi scientifica, fondata su ipotesi confermate da fatti e constatazioni empiriche. Per motivare questo convincimento, mi è necessaria una rapida ricostruzione del suo discorso. Nel tentativo di spiegare quella particolare manifestazione di violenza che è il moderno terrorismo, Musatti muove dal presupposto freudiano dell'esistenza "nella persona umana; di una componente aggressiva": la" pulsione di morte " che, per il suo carattere costitutivo e strutturante lo psichismo umano (unitamente all'altra, originaria e opposta pulsione: quella, dell'Eros, con la quale entra In rapporto dinamico e conflittuale ), è sostanzialmente incoercibile ed insopprimibile o, come dice Freud , " non neutralizzabile". Per questo suo fondamento pulsionale aggressivo, l'uomo, dunque, è naturalmente violento (omicida, distruttore ecc. ). Ne consegue -secondo Musatti -che il problema della violenza, ovvero del " perché l'aggressività umana spinga gli uomini a sopprimersi a vicenda " cessa di essere tale, in quanto, appunto, quella aggressività si svela come tratto tipico dell'uomo e della sua storia: individuale e collettiva.Il problema vero, allora, è unaltro e concerne quello " strano " fenomeno per cui, nonostante tale pulsionalità mortifera, gli uomini " non sempre... si uccidono fra loro " ed anzi giungono a condannare, proibire e, .. reprimere " lo spirito della violenza " che è in loro. - Ancora una volta, Musatti tenta una risposta sulla base della dottrina freudiana. La causa di tale " non-violenza ", infatti, è da lui individuata nella comparsa, nella coscienza umana, di " un imperativo che dice: non ammazzare ". Esso origina dal " comando genitoriale ", impartito a ciascuno " fin dall'infanzia " e che, sulla base dell'altra primitiva pulsione erotico-amorosa, " si rafforza e interiorizza, aiutato certamente come dice Freud dai processi di identificazione col prossimo ". Comando parentale, eros, identificazione con l'altro ( ovvero, formazione del concetto stesso di "prossimo") sono dunque gli elementi che, per la psicoanalisi, strutturano quei particolari meccanismi di difesa (e autodifesa) dalla pulsione di morte, che si condensano nella suddetta ingiunzione etica (o religiosa). Tali meccanismi, tuttavia, non riescono a reprimere totalmente l'aggressività pulsionale. Essi possono soltanto controllarla, diluirla nelle forme e nel tempo. Ma mai e poi mai eliminarla. Anzi, vi sono situazioni in cui quella aggressività giunge a manifestarsi proprio per il tramite di quegli stessi meccanismi. Esempi probanti di ciò sono, secondo Musatti, tanto il caso della guerra quanto quello del fenomeno terroristico. Nel fatto bellico, infatti, accade che l'imperativo del "non uccidere" pur conservando la sua natura di imperativo etico e quindi i suoi connotati di assolutezza e doverosità muta radicalmente di contenuto e segno, fino ad assumerne di diametralmente opposti : così che il "non uccidere" si " capovolge", ora, in "uccidi!". Tale mutamento si verifica è questa la specificità del fenomeno bellico in quanto l'individuo obbedisce, adesso, ad un nuovo comando di una nuova figura sociale, che egli riconosce ( e vive) come autorevole e fonte del valore: lo Stato.
Infatti, è in nome dello Stato, della sua difesa, delle sue necessità e in nome degli " assoluti " cui esso "fa appello" (la razza, la fede, la patria ecc.) che l'individuo si trasforma come dice Musatti "da persona che non avrebbe torto un capello ad alcuno" in un'altra persona che, "in piena serenità di spirito" e aggiungerei con tutto l'impegno derivante dalla consapevolezza di attuare un contenuto etico, pratica " il tiro a segno su persone vere ". Accade così, che proprio quell'imperativo etico che doveva controllare la pulsione di morte diviene lo strumento specifico di una delle sue più feroci manifestazioni. L'aggressività che era stata ricacciata negli oscuri anditi dell'" Es ", fa ora il suo ingresso trionfale, passando per la porta maestra del " Super Io ". Simile paradosso si verifica anche nel caso del terrorismo, ma, secondo Musatti, con una diversa modalità. Il terrorista, infatti, giunge all'aggressività omicida non per il tramite di " avalli esterni " ovvero, mediante una proiezione istituzionalizzata del comando parentale bensì, all'opposto, in nome di un nuovo contenuto dell'imperativo etico, di un contenuto autonomamente elaborato e" stravolto, con conseguenze tragiche ". In altri termini, se il soldato uccide sulla base di un ordine categorico e di un contenuto etico che provengono dall'esterno, secondo moduli che ricalcano quelli del primitivo comando genitoriale, il terrorista rileva Musatti al contrario, uccide contro tutti quegli ideali, quei valori, quei contenuti dell'azione morale. che si oppongono o semplicemente non coincidono con il suo ideale, con i suoi valori ecc.Anche in questo caso, pertanto, l'imperativo etico appare come la forma di espressione ( e razionalizzazione) della pulsione di morte, per il tramite di contenuti così ipertrofizzati e stravolti ( dal Super Io) da richiedere, per la loro realizzazione, tanto lo sterminio di vite umane (di quelle, in particolare, che sono ritenute il simbolo di una realtà, politico-istituzionale e socio-economica, che nega i " valori morali " del terrorista) quanto in un accecamento semi delirante e" masochistico " l'autodistruzione della vita stessa del terrorista. Risulta provata, da questi casi, la potenza della pulsione di morte, la fragilità dei meccanismi di difesa e la sostanziale inevitabilità della fenomenologia aggressivo-omicida nella storia dell'uomo. Questa, in sintesi, l'analisi di Cesare Musatti. Vediamo, ora, quei suoi punti che ci sembrano lungi dall'essere evidenti ed empiricamente accertati.
* * *
Anzitutto, la tesi della naturale aggressività umana, ovvero della strutturale inerenza di una pulsione di morte nella persona umana, quindi, della sua " innatezza ". Orbene, simile tesi è sostenibile solo a patto di dimostrare che l'aggressività umana origina dall'uomo in quanto individuo, cioè indipendentemente dalle forme storiche del suo rapportarsi alla natura e all'uomo, nella società. Giacche, se si afferma: a) che la pulsione di morte costituisce (con l'eros) lo psichismo umano, e b) che è ab initio della sua evoluzione, tanto da confondersi, quasi, col concetto di " istinto " ( 1 ), allora essa deve trovare spiegazione nella realtà immediata dell'uomo, nella sua naturalità neurofisiologica e biogenetica, al di fuori di qualsiasi mediazione sociale.
Proprio questo, però, è indimostrato e, a mio avviso, del tutto erroneo.Infatti, tutto ciò che nell'uomo è predicabile come " innato " e originario (o congenito), attiene esclusivamente e direttamente a quegli " istinti-bisogni " del mangiare, bere, dormire, riprodursi ecc. che, appunto, derivano dalla sua semplice struttura " animale ". Oltre ad essi, non è possibile derivare, dalla elementare struttura dell'individuo umano, alcun altro tipo di istinti o pulsioni. Questo perche tutte le qualità psichiche appaiono come risultati del processo di relazione dell'uomo con l'ambiente sociale-naturale e quindi possiedono i tratti della relatività, della dinamicità, della transitorietà e della inomologabilità (in un concetto definitivo). Ora, è vero che la dottrina psicoanalitica afferma e Musatti, con gli esempi della guerra e del terrorismo, lo ribadisce che la pulsione di morte si esprime in forme diverse a seconda delle circostanze ambientali e storiche. Tuttavia, non prova come tale pulsione possa esistere, indipendentemente, prima di esse: in breve, non dimostra il carattere pulsionale dell'aggressività, la sua " naturalità ". Il che, appunto, è ciò che va provato e non " dato per scontato " come dice, con ingenuo paternalismo, Musatti. Dal punto di vista della ricerca empirica e scientifico-sperimentale, sembra vieppiù comprovata sulla base, anche, delle più recenti indagini antropologiche, etnologiche e paleontologiche (2) l'ipotesi che, fatti salvi quei bisogni biogenetici cui si è accennato, l'insieme delle espressioni e dei connotati psicologici dell'uomo (comportamento, emotività, affettività) origina dal modo specifico in cui, storicamente, egli si rapporta all'ambiente naturale, sulla base delle relazioni sociali e produttive che instaura con gli altri uomini. Per cui: l'habitat (il territorio, la sua estensione, il suo clima, la sua altitudine ecc.), il modo di sostentamento e di produzione ( dall'agricoltura all'industria, dalla caccia alla pastorizia e alla moderna ricerca tecnologica ecc.), la divisione del lavoro (e quella, conseguente, delle classi) sembrano gli elementi che spiegano unitamente all'analisi del vissuto psichico infantile (ma non necessariamente familiare! ) il manifestarsi di legami solidaristici, comunitari o di istanze aggressive, distruttive e asociali. Alla luce di ciò, mi pare che l'aggressività si presenti non tanto come " pulsione ", quanto come tratto comportamentale ed emotivo-affettivo in stretta relazione (reattiva odi adeguamento) (3) ad una realtà o sistema sociale, in tutti i suoi livelli: culturale, religioso, sociale, economico-produttivo ecc..
Quindi, come una variabile ( dinamica, plastica e polimorfa) dello psichismo umano. Da ciò consegue che, lungi dall'essere risolto ( o risolvibile in termini di descrizione prescrittiva) ( 4 ), il problema del perché gli uomini si aggrediscono resta aperto e, aggiungerei, potenzialmente risolvibile attraverso I'individuazione-rimozione delle sue cause sociali ( 5 ). Perche ciò avvenga, è, però, necessario uscire dagli schemi dogmatici ( 6) dello psicanalismo, che non si prestano agilmente ad una verifica scientifico-sperimentale e che, anzi, mettono capo tanto ad esiti fatalistici ( del resto, tipici di qualsiasi posizione culturale che si fondi su un concetto di " natura umana immutabile " ) (7), quanto ad una sorprendente povertà di indicazioni operative. Come, a ben vedere, dimostra la stessa conclusione dell'analisi di Cesare Musatti. Partito con lo stabilire I'inevitabilità del manifestarsi della pulsione di morte, egli non può, infatti, rispondere adeguatamente al " che fare? " contro il terrorismo; giacché, se l'aggressività è un che di naturale, essa non può essere realmente rimossa. A meno di ricorrere all'aiuto di un dio, ma quest'ultimo non può più intervenire... perché dissolto nel concetto di Super-Io (8). Se, invece, si muove dall'ipotesi del carattere eteronomo dell'eziologia aggressiva (9) nonché della sua pluralità di significato, di direzione e di motivazione ( 10), il problema del terrorismo deve essere affrontato alla luce di altri quesiti, concernenti non tanto e non solo il perché della " fragilità " e" impazzimento " del super-io " morale " del terrorista, quanto 1) perché il terrorismo assume una dimensione sociale; 2) perché si manifesta proprio in quest'ultimo decennio in Europa; 3) perché assume forme differenziate e" originali " nei vari paesi; 4 ) perché ha avuto e, in parte, ancora ha un'area di consenso, anche intellettuale e culturale; oppure, 5) se esistono nella società: nel suo sistema economico, nei suoi meccanismi istituzionali, nella sua classe di governo, degli elementi che, almeno di fatto, spingono all'insorgenza del terrorismo, o 6) se esistono forze (economiche, politiche; interne, internazionali) che hanno interesse al mantenersi e svilupparsi del terrorismo, e via dicendo. Sono questi i punti che Musatti salta metodicamente e che, nei casi in cui li nomina, lo costringono ad uscire dalla sua ipotesi pulsionale e a contraddirsi.
Che senso ha, infatti, per chi ritiene " naturale " la violenza, auspicare che " tutto muti ", al fine di eliminare il terrorismo ?
Non significa, implicitamente, ammettere che tale fenomeno può essere abolito sulla base di una profonda trasformazione socioeconomica e politica del Paese che, mi pare, non ha molto a che fare con il lettino dello psicanalista, ma molto di più con un impegno civile e democratico ?
Ma, appunto, perché " tutto muti " è necessario abbandonare la tesi " metafisica " di Musatti ( e di certo freudismo) a favore dell'ipotesi cui accennavo prima e di un suo corollario fondamentale: quello per cui un fenomeno sociale non può spiegarsi in un'ottica soltanto psicologica, ma richiede l'intervento di strumentazioni analitiche adeguate alla complessità e ricchezza dell'oggetto di indagine (11). Il rischio che si corre, altrimenti, è quello di vedere gli alberi (fuor di metafora, il singolo terrorista) e di smarrire la foresta (il fenomeno del terrorismo ed il suo inserirsi nel sistema sociale ).
NOTE:
(1) Non a caso Charres Brenner è costretto a fare" salti mortali" per spiegare la distinzione tra " istinto" e" pulsione " nell'uomo, mostrandosi un po' imbarazzato nel rilevare come tali termini vengano usati in senso sinonimico in molta arte " della letteratura psicoanalitica ", anche di alto livello. Ciò si piega col fatto, appunto, che se è indubbiamente vero che la pulsione umana si differenzia dall'istinto animale per la sua plasticità (dovuta all'ampio spettro direzionale della risposta umana alle provocazioni ambientali), è altresì vero che, o del l'istinto, la pulsione mantiene il requisito essenziale: l'innatezza. Al punto che lo stesso capitolo del" Breve corso di psicoanalisi " (Firenze, 1967, pago 25 e segg.) di C. Brenner si intitola "le pulsioni istintuali"
(2) Su ciò, cfr. l'ampia documentazione offerta da Erich Fromm nei capp. 2, 3, 4 e 6 della 1. parte della sua " Anatomia della distruttività umana ", Milano, 1973, alle pagine (per la 3. ed., 1975) 37-40, 42-56 e 124-232.
(3) Giacche ii comportamento aggressivo può essere tanto una forma di reazione ad un ambiente sociale negativo (o vissuto come tale) quanto lo specifico modo di sopravvivenza del singolo in un ambiente che richiede ed impone, per la sussistenza fisica e emotiva, un atteggiamento aggressivo. Mi chiedo, infatti, se l'aggressività insita in molte delle relazioni maschili (altamente competitive) non generi (anche) dal messaggio culturale che vuole il maschio aggressivo, pena la sua emarginazione. Su questo problema della reazione all'ambiente del comportamento umano, si veda il famoso Sesso e temperamento di M. MEAD, Milano, 1967, specie il 2" cap. e le conclusioni.
( 4) Mi pare, infatti, che Musatti commetta un classico errore logico(-metodico): rilevando il continuo manifestarsi della aggressività nella storia dell'uomo, non si limita al livello della constatazione ma passa a quello della prescrizione, così che la ripetizione del fatto diviene elemento costitutivo della sua " legalità ", ed il" così è" si muta in " così deve essere" o "non può che essere". In tal modo, l'analisi del fenomeno non mette capo ad una spiegazione (scientifica) ma ad una tautologia che, da un lato, non possiede alcun valore gnoseologico, dall'altro sancisce l'eternità del fenomeno osservato. Per una critica di questo schema logico vizioso, si confrontino i capp. 2" e 4" della Logica come scienza storica di GALVANO DELLA VOLPE, Roma, 1969.
(5) Non si vuole, con questo, ipotizzare una società perfetta e conflittuale, bensì una organizzazione sociale tale, appunto, da vedere rimosse le cause sociali dell'aggressività negativa o distruttiva.
(6) Il dogmatismo di molti concetti psicoanalitici non risiede, a mio avviso, soltanto nel loro essere dati, con troppa disinvoltura, per " scontati ", quanto nella loro formulazione che non sempre. è funzionale alla. loro. verifica, o, popperianamente, alla loro circostanziata falsificazione. Al proposito, mi paiono ancora tutte da meditare e riscoprire le osservazioni che E. NAGEL nel suo saggio Problemi metodologici della teoria psicoanalitica (ora in Psicoanalisi e metodo scientifico, Torino, 1967) rivolge a fondamentali postulati della teoria freudiana.
(7) Ogni definizione della " natura umana" in termini assoluti e definitivi porta con sé, infatti, l'inevitabile conseguenza di assumere i limiti, i difetti, le incongruenze dell'azione storica dell'uomo come fatti inevitabili, eterni, immutabili e mette capo ad una concezione (ad una filosofia) della storia intesa come realizzazione/negazione di qualità, doti, attributi naturali, presociali e preistorici dell'uomo. Sull'inattendibilità di simili concezioni ci pare superfluo esprimerci, anche se esse, purtroppo, sopravvivono in tanta parte di ideologie politiche e sociali (vd. ad es. il liberalismo, l'umanesimo filantropico), "scientifiche" (vd. la " psicobiologia ", l'etologia, la stessa psicoanalisi) e religiose (vd. il rotestantesimo luterano, non che nuclei sostanziali o spezzoni non indifferenti di fideismo acritico).
(8) E, infatti, il pensiero cristiano, scorgendo nella natura umana ( in conseguenza della " colpa originaria" ) la causa di quel male sommo che è il " peccato ", ne scorge la soluzione (liberazione) non nell'uomo (non solo e non tanto nelle sue "opere" ) ma nella fede in Dio che giustifica, ossia nella grazia che proviene dal radicalmente" Altro-dall'uomo ", Ma ciò, appunto, non rientra in un discorso scientifico-sperimentale, bensì di fede.
(9) Dicendo eteronomo non vogliamo intendere indipendente dall'uomo, ma esterno ad esso in ordine all'origine e non alla dinamica. È ovvio, infatti, che l'aggressività si esprime sulla base della soggettiva interpretazione dell'ambiente umano sociale e naturale.
(10) È Su questa ipotesi che si muove tutta la ricerca di Erich Fromm. Si veda la già citata Anatomia dell'aggressività umana e, per quanto concerne la sua critica alla teoria freudiana degli istinti pulsionali, le pagg. 144-183 di Grandezza e limiti del pensiero di Freud, Milano, 1979.
(11) Cosa che si verifica solo a livello interdisciplinare. Come dimostra la feconda esperienza di Piaget. Si veda, su ciò, quella ricostruzione del suo iter teorico-culturale tracciata in Saggezza e illusioni della filosofia, Torino, 1972.